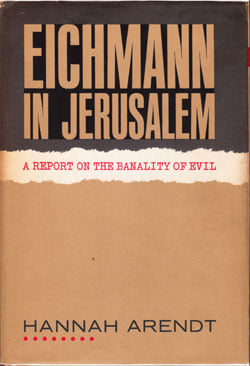
dal
processo ad Eichmann alla guerra russo-ucraina
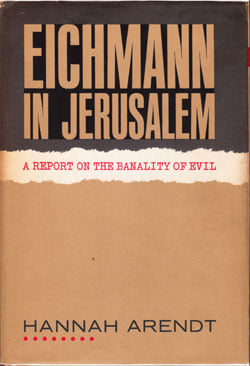
di Magali Prunai
“Eichmann a Gerusalemme: rapporto sulla banalità del male”, noto più
semplicemente come “la banalità del male”, è un saggio scritto da Hannah Arendt,
politologa, filosofa e storica tedesca naturalizzata statunitense, nel 1963.
Scritto mentre seguiva come inviata il processo ad Eichmann a Gerusalemme,
analizza l’operato dello stesso Eichmann e dei nazisti in generale giungendo,
però, a delle conclusioni inaspettate che provocarono parecchi dissensi e
malumori.
La Arendt, e per questo fu fortemente criticata, arriva alla conclusione che non
c’è mai stata una vera ragione per la quale degli uomini, anche intelligenti,
arrivarono a pensare allo sterminio di persone e che chi, meno potente, colto e
intelligente, approvava tali metodi non era semplicemente abbindolato e
impaurito dalla forza e potenza dei capi. Eichmann era perfettamente normale, e
questo fu stabilito dallo stesso processo. Eichmann non era un folle. Il suo
modo di parlare, il modo in cui esprimeva le sue idee era normale, quello che
potrebbe avere chiunque di noi. Quello che traspare fin da subito, dai resoconti
degli interrogatori e che anche l’autrice evidenzia, è che era un uomo privo di
idee proprie. Totalmente incapace di ragionare su quanto accadeva e se le sue
azioni e quelle del suo paese fossero giuste o sbagliate. Lui era interessato
solo al suo lavoro, a farlo bene, a fare carriera e diventare qualcuno. A quel
punto per lui, come per molti, un numero o un nome erano la stessa cosa. Lui
organizzava i programmi di sterminio, ma in realtà metteva tanti numeretti in
colonna su un foglio. “Non era stupido: era semplicemente senza idee (una cosa
molto diversa dalla stupidità), e tale mancanza di idee ne faceva un individuo
predisposto a divenire uno dei più grandi criminali di quel periodo”.
Hannah Arendt, nata in Germania nel 1906, si vide ritirata la cittadinanza nel
1937 poiché di religione ebraica. Scappata prima a Parigi e poi negli Stati
Uniti dopo l’invasione nazista della Francia, rimase apolide fino al 1951, anno
nel quale divenne cittadina statunitense. Giornalista e docente universitaria,
pubblicò numerosi saggi. Il più famoso, appena citato, non fu compreso. La
critica e l’opinione pubblica lo interpretarono come una difesa del nazismo,
accusandola di rinnegare le stesse ragioni per le quali era dovuta fuggire.
Morta nel 1975 per attacco cardiaco, dobbiamo aspettare il 1985 perché le sue
tesi venissero riabilitate grazie a un ciclo di conferenze organizzate a Parigi
dalla filosofa e saggista belga Françoise Collin. Finalmente, dieci anni dopo la
sua morte e a più di 20 anni dalla pubblicazione del suo saggio, si iniziò a
dare una nuova interpretazione del pensiero arendtiano.
Ma pensando alla quotidianeità degli ultimi anni, soprattutto degli ultimi
tempi, il saggio della Arendt è più che mai attuale. I protagonisti della sua
opera non sarebbero più i nazisti che sterminavano ebrei, zingari e chiunque non
fosse gradito al regime, ma tutte quelle persone protagoniste della cronache
nera, che perpetrano male senza pensarci perché non credono sia poi così
sbagliato, perché vivono in una realtà alterata, perché si voltano dall’altra
parte quando succede qualcosa e intervenire richiederebbe un dispendio di
energie troppo elevato. “Semplicemente”, e lo scrivo volutamente fra virgolette,
non pensano, ma non solo perché non hanno voglia ma perché è più semplice
lasciare ad altri il compito.
Mentre scrivevo queste riflessioni, e pensavo alla cecità dell’uomo moderno
davanti alle stragi in mare o a tutte quelle guerre e guerriglie e atti di
terrorismo che dominano il mondo da tempo ormai immemore, è scoppiata un’altra
guerra. Tra il clamore popolare e un’alzata di scudi vari, i commenti sulla
sanità mentale di chi ha messo in piedi quella che rischia di diventare a tutti
gli effetti una terza guerra mondiale mi hanno riportato alla mente il giudizio
su Eichmann. Non è necessario essere pazzi per decidere di mandare a morte
migliaia di persone.
Basta essersi abituati e qualsiasi cosa, anche la peggiore, diventa normalità.
Ma senza scomodare una situazione così delicata, potrei citare mille esempi di
persone normali, come me o chi legge in questo momento, che ormai viziata dalla
cultura del tutto e subito, ha “perso la pazienza”, compiendo stragi familiari
in risposta a un rifiuto, davanti a un capriccio non assecondato.
E questa pare essere la società 2.0, quella del futuro che deve salvare il mondo
dalla povertà, dall’emergenza climatica ma che è diversa dalla precedente solo
nell’accesso alla tecnologia.
Il male è banale, perché chi lo commette non pensa neanche se sia giusto o
sbagliato. Se si fermasse a pensare non compirebbe gesti tanto atroci. La
società odierna è di nuovo senza idee, si è abituata a lasciare ad altri il
compito di ragionare per lei e la vita della maggior parte di noi ormai altro
non è che una perenne attesa che qualcosa accada senza mai realmente impegnarsi.
E ciò che aggrava la situazione è che, oltre a non avere idee, l’uomo moderno è
convinto di conoscere tutte le verità del mondo, portando avanti teorie
inverosimili e improbabili.